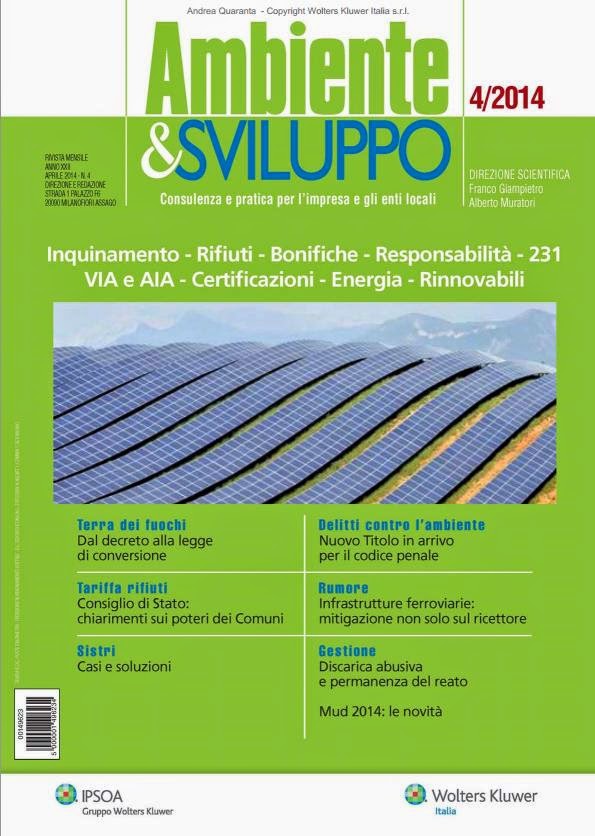Poco più di un anno fa è stato pubblicato, sulle pagine di questa rivista, un articolo sul pubblicizzato nuovo incenerimento dei rifiuti dal sapore – per così dire – enigmistico:
l’articolo, infatti, invitava il (più che) paziente lettore a
soffermarsi sulle differenze apportate in materia dal decreto legge
#SbloccaItalia, prima, e a stretto giro dalla sua legge di conversione, e
a domandarsi quale fosse il senso di quel “fare e
rifare, che è tutto un lavorare”, secondo l’icastica, lapidaria ed
efficace sintesi proverbial-dialettale, ivi citata.
Perché il punto, come si avrà modo di
evidenziare nel prosieguo di questo articolo, è – continua ad essere –
proprio questo: per dare delle risposte efficaci, occorre sapersi fare
le giuste domande. Non limitarsi ad ingegnosi make-up linguistico-normativi buoni solo per comunicare il risultato di un laborioso
(quanto inutile) lavoro di una “riforma”, da vendere ai
cittadini-consumatori, molto più numerosi non solo degli addetti ai
lavori (nelle cui fila militano anche gli assolutori – del lavoro del
Governo di turno – a priori), ma soprattutto di chi prova a far
emergere il proprio motivato dissenso non (solo) tanto alla scelta in
quanto tale, quanto alla sua realizzazione contestualizzata.
E invece, sulla scia di quel metodo di lavoro tanto caro ai nostri ambidestri legislatori, (e con il consueto ritardo), ci ritroviamo, oggi, a ri-discutere non solo di questa opinabile scelta di metodo, ma anche del suo “merito” (la bozza in progress non appare esente da critiche) e, più in generale, della coerenza di chi continua a spacciarla per…
A spacciarla, confondendo i suoi alibi e
le ragioni di chi (anche in questo caso sono in tanti) vorrebbe un
sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti reale, e non
annunciabile.
Le prime "risposte" a non si sa quali domande di sostenibilità
La bozza di decreto, finalmente analizzabile
a luglio dello scorso anno, contiene fin dalle premesse i richiamati
elementi di incoerenza politica: magari a sua insaputa, ma sta di fatto
che il legislatore ha utilizzato anche in questo caso, quella
“tecnica” che consiste (anche) nel far di volta in volta riferimento o a
comodi elementi esterni alla volontà politica di chi “è costretto ad
agire” (va di moda, ad esempio, trincerarsi dietro al “ce lo chiede
l’Europa!”), o a quegli stessi elementi esogeni, ma per sostenere, al
contrario, posizioni politico-elettorali di segno opposto (ad esempio:
“l’Europa non può dettarci le regole!”).
In un momento storico in cui quotidianamente echeggiano gli strali anti ingerenze europee, il nostro legislatore giustifica questa scelta anche con la necessità di attuare il “progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale”, di “tenere conto della pianificazione regionale” e di “superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione” comunitarie.
Sulla base:
- di queste di per sé inoppugnabili premesse (ma fin qui siamo alle parole);
- degli altrettanto indiscutibili principî di gerarchia nella gestione dei rifiuti (in relazione ai quali, tuttavia, il legislatore ha scelto – non si capisce se a sua insaputa o se per noncuranza – di muoversi su un terreno minato), e
- del continuo richiamo a diverse tipologie di un non meglio specificato “fabbisogno” di trattamento e di incenerimento (per l’interpretazione del quale occorre, a questo punto, affidarsi a qualche aruspice),
la prima bozza di decreto si struttura come segue [...]
L'articolo prosegue con un capitolo
intitolato "Le risposte rivedute e corrette e l'utilizzo del Photoshop
giuridico", e un altro che analizza le risposte date dalle regioni al maquillage al quale era stato medio tempore sottoposto il DPCM.

"[...]
Nella“Guida galattica per autostoppisti” –
serie di romanzi di fantascienza umoristica – un supercomputer,
realizzato per cercare la risposta alla “domanda fondamentale sulla
vita, l’universo e tutto quanto”, dopo sette milioni e mezzo di anni
fornisce la risposta: “42”.
«“Quarantadue!” urlò Loonquawl. “Questo è tutto ciò che sai dire dopo un lavoro di sette milioni e mezzo di anni?”
“Ho controllato molto approfonditamente” disse il computer, “e questa è sicuramente la risposta. Ad essere sinceri, penso che il problema sia che voi non abbiate mai saputo veramente qual è la domanda”»
Fatti gli opportuni distinguo, e con il Massimo
rispetto per il ruolo, anche la politica 2.0, nonostante le premesse,
sembra seguire – nei fatti, e per utilizzare un vocabolario comunicativo,
e in quanto tale approssimativo, ma in ogni caso efficace – lo stesso
schema da “prima Repubblica”, infarcito di asserzioni aprioristiche,
di espressioni normative sfarzose, di enunciazioni di principî solenni,
di una comunicazione raffinata quanto vacua, di risposte generiche e
contraddittorie a domande spesso sbagliate e in ogni caso non
circostanziate né contestualizzate, quelle rare volte che il politico
nelle vesti di legislatore (e non di comunicatore) ipotizza di risolvere
i problemi partendo dall’analisi delle necessità, e quindi dalle domande.
Come si accennava in premessa, e
probabilmente come conseguenza dell’assertività governativa e della
relativa assenza di dubbi sul metodo e sul merito anche di questa
scelta, le domande – che avrebbero dovuto, che dovrebbero indirizzare il legislatore – sono le grandi assenti anche di questa ennesima riforma ambientale.
Ed il legislatore fornisce, non può che
fornire, risposte prive di significato, di soluzioni, di efficacia: si
potrebbe quasi dire, a valle della lettura di questi testi, se la
situazione non fosse così grave, che il legislatore sia portato più per
la fantascienza umoristica che per governare le sorti di un Paese.
Volendo sintetizzare le criticità che, a
parere di chi scrive, emergono dalla lettura dell’articolato normativo,
si possono enucleare almeno tre categorie.
La prima, difficilmente riassumibile con
un unico aggettivo, ha a che fare con l’innato carattere del nostro
legislatore, poco incline a farsi domande, più propenso invece a far
vedere di fare (soprattutto a dire) qualcosa e a manipolare le parole.
Tali criticità si manifestano:
- a volte in modo palese, ad esempio laddove il legislatore continua a volersi riferire al fatto che tali impianti di “termovalorizzazione” “costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, e realizzano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti”: parole (parole parole) dotate evidentemente di poteri taumaturgici (per il legislatore), ma soprattutto autoassolutorie e funzionali alla comunicazione tautologica e martellante che domina la scena politica degli ultimi anni;
- a volte in modo più sfumato, e quindi potenzialmente ancora più pericoloso, sotto forma di altri ipse dixit distorsivi del senso delle parole e/o della comunicazione e/o di quella che dovrebbe essere la ratio della normativa ambientale, più in generale.
Ne costituiscono un esempio il disinvolto richiamo a diktat esogeni, per giustificare qualsiasi decisione, specie se impopolare; l’utilizzo approssimativo di una terminologia non sempre coerente, sia che si tratti di “terminologia di dettaglio”, sia che si tratti di definizioni anche all’apparenza più cogenti, sia che si tratti, infine, di espressioni dirimenti per capire il contesto operativo; il pedante richiamo ad una gerarchia di gestione dei rifiuti diversa da quella reale, e modellata sulla base degli obiettivi (ehm: interessi) che si intendono raggiungere; la possibilità concessa di revisionare periodicamente le previsioni del decreto, salvo farlo soltanto “in presenza di variazioni documentate” (in sostanza: solo a consuntivo, e non in base alle previsioni delle programmazioni regionali per il futuro…); la nuova formulazione
delle disposizioni finali (comma 6), laddove il legislatore stabilisce
che per le modifiche del decreto, si debba tener conto anche delle
politiche in atto relative alla dismissione di impianti o alla riduzione
di capacità di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da una
sovraccapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di
incenerimento.
L’intenzione, in questo caso, sembra essere quella di “depotenziare il conflitto istituzionale con la Lombardia, ove il caso della sovraccapacità è clamoroso”, salvo farlo “senza
alcuna coerenza con la previsione fondamentale della bozza che,
individuando solo l’incenerimento come destinazione ultima del rifiuto
residuo, cancella le previsioni, incluse nella precedente bozza, dei 3
nuovi inceneritori per il Nord”.
Quest’ultimo passaggio ci permette di passare al secondo filone di criticità: quello delle incongruenze/contraddizioni.
La più evidente – ma non per chi ha ipotizzato queste
risposte – è quella che non riesce a rispondere alla seguente domanda,
per il semplice fatto di non essersela posta: perché puntare
sull’incenerimento dei rifiuti, con questa presunta fretta “non
operativa” (ma senz’altro con frettolosità), in un momento in cui la
produzione di rifiuti è in netto calo?
E/ma soprattutto, perché puntare in questo modo così “cautelativo”
sugli inceneritori che, per definizione, hanno una continua necessità
di ricevere rifiuti, e per stessa ammissione del legislatore in passato
sono stati sovradimensionati?
Non si tratta, con tutta evidenza, delle
domande che chi legifera dovrebbe porsi prima di intraprendere un
percorso normativo, quanto piuttosto di interrogativi ex post che sorgono dalla lettura di queste risposte…
Viene da chiedersi, inoltre, ad esempio:
- perché, stando così le cose, il legislatore afferma, in premessa, che “l’individuazione di un fabbisogno basato su percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti urbani e assimilati, determinerebbe una capacità impiantistica sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali”?
Senza contare il fatto che “gli impianti di trattamento
preliminare hanno una capacità spesso superiore rispetto al fabbisogno
di trattamento calcolato su una quantità di rifiuti residui derivanti da
una raccolta differenziata a norma di legge”.
- perché non si coordina
la sedicente “strategia dell’incenerimento” (o incenerimento delle
strategie?) con quanto di recente approvato con la legge sulla green economy, la quale prevede una serie di interventi che vanno in assoluta controtendenza rispetto a questa bozza di decreto?
L’ultima, ma non meno importante,
contraddizione, è quella che riguarda l’assenza di qualsiasi connessione
con gli scenari delineati nel “Pacchetto sull’economia circolare”, adottato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2015 per promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare
che aumenterà la competitività globale, sosterrà la crescita economica e
genererà nuova occupazione.
Il pacchetto – che contiene alcune proposte legislative riviste sui rifiuti nonché un piano d'azione globale,
sulla base di una visione chiara e ambiziosa di lungo termine per
aumentare il riciclaggio e ridurre il collocamento in discarica – parla anche di incenerimento, ma in termini (non mistificatori) più
realistici, anche se utilizza il termine termovalorizzazione in modo
giuridicamente border line…
Alla precisa domanda (“Nell'ambito di queste proposte è ancora permesso l'incenerimento dei rifiuti?”) la Commissione, infatti, risponde affermando che “se
non è possibile evitare di produrre rifiuti né è possibile riciclarli,
recuperarne il contenuto energetico è di norma preferibile al
collocamento in discarica, sia sotto il profilo ambientale che
economico. Vi è quindi spazio per la termovalorizzazione, che contribuisce a creare sinergie con le politiche unionali in materia di energia e clima, ma sempre seguendo i principi della gerarchia dei rifiuti stabilita dall'UE.
La Commissione esaminerà come ottimizzare questa pratica, senza
compromettere il potenziale di realizzazione di tassi di riutilizzo e di
riciclaggio più elevati e come sfruttare al meglio tale potenziale
energetico. A tal fine la Commissione adotterà un'iniziativa sulla
termovalorizzazione nell'ambito dell'Unione dell'energia”.
Si tratta, in sostanza, di una questione di numeri, che rappresentano la terza e – almeno alla fine di questa prima lettura – ultima criticità di questa bozza.
Come s’è visto, i conti non tornano già solo se si considera il trend
decrescente della produzione di rifiuti; a ciò si deve aggiungere che
non vi è nessuna revisione dei calcoli per le Regioni con nuove
programmazioni in corso di preparazione e che anche la terminologia utilizzata – non ulteriormente specificata –
lascia ampi margini di movimento, sia in relazione ai presupposti
localizzativi, sia con riguardo alla vera e propria realizzazione “di un sistema moderno ed integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”.
La normativa, specie quella ambientale, non ha bisogno di continui ritocchi di facciata, ma di essere presa sul serio e di dare
risposte precise domande strategiche.
Ma chi di dovere queste domande se le deve porre consapevolmente prima, e non dopo che un altro danno si è verificato.
In quel caso, infatti, si tratta al
massimo domande retoriche, quando non semplici constatazioni
interrogative di quello che è accaduto, e che si sarebbe potuto evitare,
ma buone in ogni caso per giustificare altre scelte emergenziali.
E le risposte non sono quelle
programmatorie e strategiche di cui abbiamo bisogno (e che ci
aspetteremmo), ma semplici risposte (para-umoristiche) che – come diceva
quel(l)o – il legislatore ha dentro di sé.
E che, però, sono sbagliate.
Read more