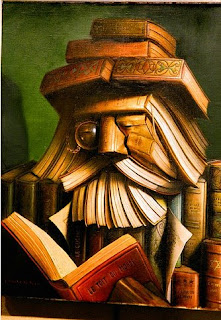Anch’io ho partecipato in qualità di relatore: nel mio intervento ho cercato di delineare, contestualizzandolo, il ruolo delle regioni nella
politica ambientale.
Per ovvi motivi di tempo, non ho potuto scendere a livello di dettaglio: per questo motivo ho predisposto, per chi volesse approfondire, una relazione, il cui testo completo si può scaricare sul sito internet di
Natura Giuridica.
Quello che segue è un breve riassunto.
La mia analisi è partita da un citazione del Prof. Maddalena, Giudice della Corte Costituzionale, che:
- ha sottolineato la difficoltà di definire l'ambiente sul piano giuridico, e di indicare i presupposti giuridici della sua tutela;
- ha posto l’accento sulla profonda crisi del sistema normativo, nel quale il diritto, diventato pura forma e procedimento (osservati questi, qualsiasi interesse può prevalere…) ha perso molta della sua forza) e
i valori tradizionali, ed in particolare il valore della giustizia, sembrano regredire di fronte all'avanzata, possente e distruttiva insieme, dell'interesse economico.
Questa crisi in campo ambientale è più evidente che mai, e investe tutti i livelli di governo.
Di qui si è, quindi, sviluppata la mia analisi:
- sull’evoluzione della legislazione normativa italiana che, figlia di un modo di legiferare perennemente emergenziale (…continuamente prorogato…), ha creato notevoli problemi pratici fra gli operatori del settore, ha influito negativamente sullo sviluppo economico del nostro Paese (frenandolo) e, soprattutto, ha impedito un’efficace tutela dell’ambiente. Legislazione che neanche il c.d. Testo Unico Ambientale è riuscito a razionalizzare, semplificare e coordinare (di questo ho già cominciato a parlare nelle pagine di Natura Giuridica).
- sul ruolo della giurisprudenza nella tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo.
Effettuata questa doverosa premessa, necessaria per contestualizzare il mio intervento, ho:
- sottolineato che la crisi del diritto ambientale si complica se, dal livello nazionale, ci si spinge ad un’analisi delle varie legislazioni regionali;
- evidenziato le problematiche attinenti alla ripartizione delle competenze Stato-Regioni, così come stabilite nel Testo Unico Ambientale;
- sintetizzato la giurisprudenza della Corte Costituzionale,
al fine di verificare, in concreto, quali sia il ruolo della Regione nella materia de qua.
Dopo una breve panoramica della
politica ambientale piemontese, prima delle conclusioni ho sottolineato l’importanza dell’
InFormazione e della comunicazione dell’ambiente in generale, e del
diritto ambientale: cioè la
mission di
Natura Giuridica.
Anche le conclusioni iniziano con una citazione.
Se, come dice Aristotele, la legge non ragiona di cose particolari e presenti, ma di cose future e generali e se il futuro (specie in ambiti in cui sono coinvolte questioni tecnico-scientifiche) è caratterizzato dall’incertezza, dalla varietà dei casi ogni giorno più sorprendenti, non si può non convenire che il diritto ambientale dimostri come il legislatore tenda ad essere sempre più spesso scavalcato, ridimensionato e limitato.
"E infatti, costretto nelle pastoie di procedure lunghe e complesse, sballottolato nel teatro nazionale della politica, questi resta costantemente indietro rispetto al regolato formale, affannandosi in una sorta di corsa contro il tempo che inevitabilmente produce sovrapposizioni, contrasti incertezze".
Credo, in estrema sintesi, che l’unica azione credibile, dopo anni di velleitarie politiche settoriali, consiste in interventi coordinati e razionali, strutturali e strutturati, sia in campo giuridico che in campo economico: una politica dell’ambiente integrata e di ampio respiro, dinamica, che sia al tempo stesso incentivante e dissuasiva, adeguata e, soprattutto, effettivamente operativa, capace di dare, finalmente, una seria e concreta risposta all’esigenza di tutela, troppo a lungo disattesa.
Questo a livello di politica ambientale.
Ma “le odierne sfide ambientali impongono di guardare oltre l’approccio strettamente normativo e di assumere una strategia su più fronti, capace di indurre i necessari cambiamenti dei nostri modelli di produzione e di consumo”.
In sostanza, non è sufficiente “delegare” il problema ambiente alla classe politica, per pensare di poterlo risolvere: occorre responsabilizzarsi, uscire dal pantano di cinismo rassegnato in cui ci dimeniamo, dalla miopia culturale.
Bisogna prendere coscienza e consapevolezza delle possibilità e del potere dei piccoli gesti quotidiani, cominciare a informarci, comunicare, dialogare e collaborare veramente, come capita in altri paesi più civili del nostro, per la costruzione di un bene comune: in sostanza, formare una solida cultura della legalità ambientale.
Fondamentale, in questa prospettiva, è il ruolo della governance, ovvero di un nuovo modo di governare, basato su un approccio condiviso ed allargato, alternativo al tradizionale intervento politico dall’alto: nell’attuazione delle politiche ambientali diventano così prioritari i comportamenti degli attori pubblici e privati, di interessi economici e di singoli cittadini, quotidianamente chiamati, con le loro azioni, a mettere in pratica la sostenibilità.
Da ciò l’importanza della comunicazione e dell’informazione ambientale, volte a rendere consapevole il cittadino delle problematiche ambientali e delle politiche mese in atto per la loro risoluzione.
Foto
Torino B&W originally uploaded by
Semaone.